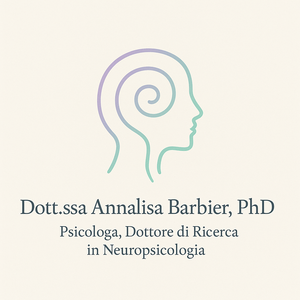GLOSSARIO
-
DISTURBI AFFETTIVI STAGIONALI: sono alterazioni del tono dell'umore e del comportamento che compaiono ai cambi di stagione, in particolar modo a partire dall'autunno. Ne sono colpiti oltre tre milioni di italiani, soprattutto donne fra i 20 e i 40 anni. All'origine di questi disturbi sono fattori legati al cambiamento dei cicli luce-buio, in particolare alla riduzione delle ore di luce, che influenza la produzione di neurotrasmettitori come la serotonina e di ormoni quali la melatonina, alterando i normali ritmi biologici. Le caratteristiche del disturbo sono le seguenti:
- Corrispondenza tra la comparsa dei sintomi e particolari periodi dell’anno;
- Attenuazione o remissione completa del disturbo in periodi dell’anno altrettanto precisi;
- Cambiamento stagionale delle abitudini alimentari: aumento dell’appetito con forte desiderio di carboidrati, dolci, caffeina, e conseguente aumento di peso;
- Facile irritabilità, pigrizia, malinconia, difficoltà nei rapporti interpersonali e sul lavoro;
- Calo del desiderio sessuale;
- Insonnia o, al contrario, ipersonnia (tendenza/desiderio di dormire molte ore anche durante il giorno) - DISREGOLAZIONE EMOTIVA: con questo termine si indica la difficoltà nel gestire o elaborare efficacemente le emozioni. Si può manifestare attraverso una eccessiva ed incontrollata intensificazione delle emozioni (scoppi di ria o perdita di controllo) oppure attraverso una esclusione e "disattivazione" delle stesse, che porta ad una sorta di appiattimento emotivo e scarsa manifestazione emozionale
- DEPERSONALIZZAZIONE: Alterazione psichica per la quale si perde il senso della propria identità e si sente come estraneo il proprio corpo (Diz. Hoepli), presente del Disturbo Dissociativo. La persona presenta un’alterazione grave e perturbante della percezione o dell’esperienza di sé per cui prova un improvviso senso di distacco o di estraneità a se stesso: gli arti possono apparire di forma drasticamente diversa dal solito, oppure può avere l’impressione di essere fuori dal proprio corpo, come se si vedesse dall'esterno, oppure ha l’impressione di muoversi in un sogno.
- DEREALIZZAZIONE: È un malessere psichico per cui si perde contatto con la propria realtà ambientale, che viene vissuta come fittizia. La persona affetta ha l’impressione di muoversi come in un sogno. Esperienza in cui il soggetto percepisce come estraneo l'ambiente che lo circonda: può avvertire la sensazione che il mondo sia “strano” o irreale, di vivere un sogno, di sentirsi tagliato fuori dal mondo o di percepirlo come attraverso una ecc.
- DISTURBO DI PERSONALITÀ': In psichiatria e psicologia clinica, un disturbo di personalità indica manifestazioni di pensiero e di comportamento disadattivi che si manifestano in modo pervasivo (non limitato a uno o pochi contesti), inflessibile e apparentemente permanente, coinvolgendo la sfera cognitiva, affettiva, interpersonale ecc. della personalità dell'individuo colpito. Si parla di disturbo nel momento in cui tale manifestazione sintomatologica causa disagio clinicamente significativo.
- COMPULSIONI: Le compulsioni possono essere definite "covert" ossia atti mentali, come il contare, pregare, ripetere parole ecc. o "overt" , cioè comportamenti qiali il ripetuto controllare, pulire, ordinare che hanno carattere di ripetitività, e vengono messi in atto in risposta ad un’ossessione secondo regole precise, allo scopo di neutralizzare e/o di prevenire un disagio e una situazione temuta. Le compulsioni fanno parte dei tentativi di soluzione che il paziente mette in atto per prevenire o neutralizzare la minaccia rappresentata dalle idee ossessive.
- OSSESSIONI: sono idee, pensieri, impulsi o immagini che insorgono improvvisamente nella mente del soggetto e che vengono percepiti come intrusivi, fastidiosi e privi di senso. Le ossessioni occupano la mente del soggetto procurandogli disagio e possono essere ricorrenti quando si ripresentano alla mente con frequenza e/o persistenza, ovvero quando occupano la mente in modo continuo e estremamente fastidioso, compromettendo la qualità della vita della persona affetta.
- RELAZIONE FUSIONALE: è una relazione in cui sono andati perduti i reciproci confini personali ed in cui entrambi i partner si comportano come se fossero "una sola cosa": fanno tutti insieme, non si allontanano mai l'uno dall'altro, necessitano della presenza reciproca peer svolgere qualsiasi attività, hanno bisogno assoluto l'uno dell'altro. Prevale una sorta di auto e reciproca limitazione di tempi e attività esterne. Si tratta di una relazione disfunzionale in quanto limita grandemente la possibilità di crescita ed individuazione dei soggetti che ne fanno parte.
- STILE DI ATTACCAMENTO: In psicologia, l’attaccamento definisce un sistema complesso e dinamico di comportamenti ed emozioni che contribuiscono alla costruzione ed alla caratterizzazione di un legame specifico fra due persone. Fu Bowlby a studiare l’attaccamento, definendone caratteristiche, origine, funzione ed esiti nella sua Teoria dell’Attaccamento. Le radici profonde dell'attaccamento risalgono alla costruzione delle relazioni primarie che il bambino stabilisce con le figure di riferimento e di accudimento (ad esempio, la madre) nei primissimi anni della sua vita, e caratterizzeranno in futuro tutte le relazioni intime che sperimenterà da adulto.
- Il SENSATION SEEKING secondo Zuckerman (1994) è “un tratto definito dalla ricerca di comportamenti a rischio, sensazioni ed esperienze varie e intense, e dalla disponibilità a correre rischi fisici, sociali, legali e finanziari, per il piacere di tali situazioni”, che raggiunge la sua massima espressione nel periodo giovanile coinvolgendo ragazzi di età sempre minore (Boyer, 2006; Macrì, Canicattì, Duetti, Pizzo, Filipponi & Galeazzi, 2011).
DAL PROBLEM SOLVING ALLA PRESENZA CONSAPEVOLE: il dono di abitare il presente
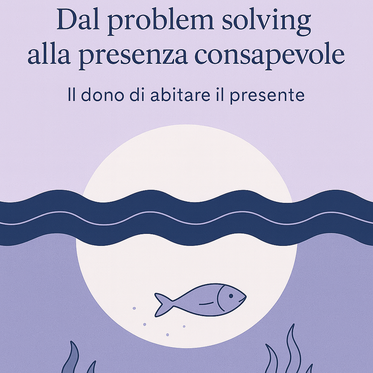
Viviamo immersi in una cultura che celebra il “fare”, il migliorarsi, il raggiungere “sempre di più” …La produttività, l’attenzione agli obiettivi da raggiungere, la capacità di risolvere problemi e di muoversi rapidamente da un punto A a un punto B appartiene alla modalità del fare che, pur essendo una dimensione indispensabile per la vita quotidiana, poiché grazie ad essa costruiamo, pianifichiamo, impariamo, ci evolviamo - può diventare anche il nostro peggior nemico.
Come scrive il filosofo Han, viviamo nella società dell’ “autosfruttamento”, in cui siamo noi i nostri stessi “sfruttatori”: spinti a fare sempre meglio… di più… abituati ad usare una dura e dolorosa autocritica nell’illusione che possa servire a renderci “migliori”… sempre migliori.
Tuttavia, quando la mente rimane intrappolata esclusivamente in questo registro, qualcosa si perde: la possibilità di abitare pienamente l’esperienza, di sentire la vita mentre accade, di accogliere le cose per come si presentano invece di pretendere che siano come vorremmo o pensiamo che dovrebbero essere. ci spostiamo dal “qui ed ora” agli spazi vuoti di “ciò che manca”.
Qui entra in gioco la modalità dell’essere, cuore della pratica di mindfulness, ad aiutarci e riportare equilibrio ed una prospettiva più spaziosa e aperta.
LA MODALITÀ DEL “FARE”
La modalità del fare è orientata allo scopo e funziona come un radar molto preciso: individua la distanza tra “come sono ora” e “come vorrei essere”, o tra “come vanno le cose” e “come dovrebbero andare” e mobilita pensieri e azioni per colmare lo scarto. Guarda solo gli spazi vuoti e perciò vuole riempirli, perché questo è quello che fa. È la modalità che ci guida quando organizziamo una giornata di lavoro, quando impariamo una nuova lingua, o quando risolviamo un problema pratico. Dunque va bene in molti ambiti ed è anzi molto importante.
Questa dimensione, tuttavia, applicata alle emozioni e agli stati interiori può diventare un terreno fertile per l’insoddisfazione e la sofferenza.; ad esempio, se mi sento triste, la modalità del fare cercherà immediatamente delle strategie per “eliminare”, risolvere, cambiare e allontanare quella tristezza, mi dirà che dovrei essere diverso, migliore, più sereno, che dovrei essere “positivo” ecc... Paradossalmente, questo tentativo di correzione che nasce in buona fede, è un meccanismo in grado i esacerbare e rafforzare la sofferenza stessa, spesso chiudendoci in un circolo vizioso di sofferenza e giudizio negativo sul fatto che stiamo provando sofferenza.
LA MODALITÀ DELL’ESSERE
La modalità dell’essere è radicalmente diversa: essa non è orientata a un obiettivo ma ad essere presenti nell’esperienza diretta. In questa modalità, la mente non cerca di cambiare o giudicare ciò che accade, ma si apre al momento presente così com’è, senza giudicarlo nè perdersi in narrazioni su di esso.
Nell’essere non c’è nulla da raggiungere: c’è piuttosto un lasciar accadere, un lasciar fluire. È la capacità di restare con ciò che sentiamo — che sia gioia, tristezza, pace o agitazione — senza doverlo immediatamente trasformare o allontanare. E’ importante comprendere una cosa: essere, lasciar accadere senza forzare le cose, non significa passività, ma è piuttosto un’attitudine di presenza e accoglienza, che spesso genera - spontaneamente e indirettamente - chiarezza, saggezza, pace interiore, conoscenza.
Ecco un esempio ed una metafora evocativa che possono aiutarci a comprendere meglio la differenza tra modalità del fare e modalità dell’essere:
1) immaginiamo di fare una passeggiata in un parco:
Quando siamo nella modalità del fare, potremmo contarla come esercizio fisico, misurare i passi o il battito cardiaco o la velocità dell’andatura al fine di ottimizzare l’esercizio, oppure pensare a come “ottimizzare” il tempo che state trascorrendo. Se siamo invece nella modalità dell’essere, ci lasciamo attraversare e toccare dai colori, dal profumo dell’aria, dal rumore delle foglie sotto i piedi, ci apriamo con curiosità ad osservare ciò che sta accadendo momento dopo momento, fuori e dentro di noi… sentiremo le sensazioni che sorgono e tramontano in noi di fronte agli stimoli esterni. Non sti amo camminando per ottenere un risultato, ma per il piacere puro e semplice di essere nel cammino, e di godere dell’esperienza.
2) Immaginiamo l’oceano:
La superficie agitata rappresenta la modalità del fare: movimento, scopo, tensione costante.
Gli abissi calmi e immoti incarnano la modalità dell’essere: silenzio, profondità, osservazione pura.
Quando la vita richiede adattamento, agilità, sforzo, determinazione, soluzione di problemi e ricerca di strategie allora è utile ricorrere alla modalità del fare; ma questa continua concitazione ci allontana da noi stessi, ed è in questo momento che la modalità dell’essere ci viene in aiuto: offrendoci la possibilità di sperimentare quiete, presenza, possibilità.
Entrambe le modalità sono preziose, ma quando siamo troppo nella modalità del fare, ci carichiamo di conflitti non necessari e spesso dannosi.
Non si tratta di eliminare il fare, ma di riconoscerne i limiti e di riscoprire e valorizzare la dimensione dell’essere, soprattutto quando ci relazioniamo con la nostra vita interiore. La mindfulness ci invita proprio a fare questo: ad allenare la capacità di sostare, osservare e sentire, riposare nel momento presente, così che la nostra esistenza non sia una corsa incessante verso ciò che manca, ma un incontro vivo con ciò che c’è.
Ricordiamo: “Il non-fare non è inattività, è permettere che le cose siano” (Cit.)
In questo spazio, l’essere e il fare si riconciliano e tornano in equilibrio, e dalla quiete dell’essere può nascere una forma di agire più consapevole, umano ed autentico.
Se vuoi approfondire come sviluppare la modalità dell’essere, puoi leggere il mio articolo
I 7 PILASTRI DELLA MINDFULNESS
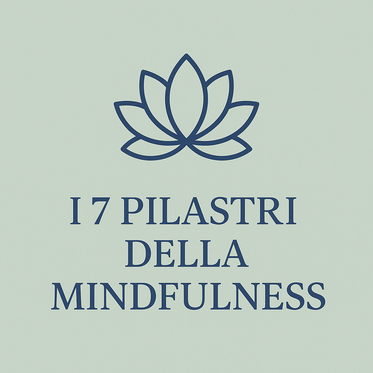
Jon Kabat-Zinn, verso la fine degli anni Settanta, ha ideato e iniziato ad usare i protocolli MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) in occidente. Tali protocolli traggono origine dalle pratiche meditative del buddismo rese “laiche”, separate cioè dagli aspetti spirituali che le accompagnano, per essere adattati alla cultura e alle necessità dei partecipanti occidentali.
Inizialmente nato per aiutare i pazienti affetti da dolore cronico e malattie terminali, il protocollo MBSR si è rivelato negli anni - grazie a numerosi studi che ne hanno validato l’efficacia - un protocollo di grande efficacia e utilità in molte condizioni: sono infatti in grado - se seguiti con costanza e impegno - di alleviare la sofferenza emotiva e fisica, migliorare la gestione dello stress e promuovere il benessere psicofisico del praticante. E’ importante qui sottolineare che i benefici vengono da una pratica costante della meditazione di consapevolezza e che non è sufficiente seguire il protocollo di 8 settimane se non se ne integrano poi gli insegnamenti nella propria vita quotidiana.
Infatti, la pratica di consapevolezza non si riduce all'applicazione meccanica di tecniche o istruzioni predefinite; essa richiede piuttosto un vero e proprio cambiamento di prospettiva nell'atteggiamento verso l'esperienza. L'elemento cruciale che caratterizza questo cambiamento, è l’assunzione di una apertura radicale verso l’esperienza, non giudicante e presente; la capacità di coltivare la disposizione ad accogliere pienamente ciò che si presenta, momento dopo momento, senza pregiudizi o preconcetti. Solo attraverso questa trasformazione è possibile coltivare la profonda accettazione della realtà, nella sua interezza e complessità. Accettare la realtà "così com'è" non implica passività o rassegnazione, ma piuttosto una comprensione chiara e lucida del momento presente, senza le distorsioni create dai nostri desideri, paure o aspettative.
Kabat-Zinn identifica sette atteggiamenti “chiave” che definisce “pilastri” e che hanno un ruolo fondamentale nell’approcciarsi alla pratica meditativa affinché se ne possano accogliere davvero i benefici nella propria vita. I “7 pilastri della mindfulness” di cui parlerò nell’articolo non sono semplici concetti teorici, ma importanti qualità, atteggiamenti profondi interiori che possono essere coltivati e integrati nella nostra esperienza.
1. Non Giudizio: essere testimoni imparziali dell’esperienza
Quando portiamo l'attenzione al flusso dei nostri pensieri, emozioni e sensazioni, ci rendiamo rapidamente conto di quanto la nostra mente sia continuamente dedita a giudicare e valutare la nostra esperienza; questa tendenza a giudicare, che spesso opera a un livello subconscio, colora la nostra percezione della realtà come un filtro, interpretando, giudicando, criticando… contribuendo in tal modo ad alimentare significativamente la sofferenza. Il giudizio può manifestarsi in molte forme: critica verso noi stessi o gli altri, etichettature, paragoni, preferenze rigide e aspettative irrealistiche. Questi giudizi creano e mantengono in essere una sorta di "lente colorata" che distorce il modo in cui cui vediamo il mondo, impedendoci di sperimentare la realtà in modo più diretto e autentico. Per coltivare il non giudizio, è essenziale assumere il ruolo di "testimone imparziale" della nostra esperienza: ciò significa imparare ad osservare i pensieri, le emozioni e le sensazioni (fenomeni) che sorgono, attraversano ed escono continuamente nella nostra mente, senza reagire automaticamente ad essi, senza cercare di sopprimerli o modificarli, senza lasciarcene trascinare in loop di pensiero o reattività emotiva. Quando sorge un giudizio, semplicemente lo riconosciamo per ciò che è: un pensiero, un fenomeno mentale impermanente, senza identificarci con esso. Questa pratica ci permette di sviluppare una maggiore consapevolezza dei nostri schemi di pensiero abituali e di liberarci dalla loro presa, aprendo la strada a una maggiore pace interiore e accettazione di sé. crediamo uno spazio aperto, leggero e libero in cui poter dimorare.
2. Pazienza
La pazienza è una virtù spesso trascurata nella società moderna, che invece è sempre più orientata alla velocità e all'ottenimento immediato di risultati. Tuttavia, la pazienza è un elemento essenziale nella pratica della mindfulness e nella vita in generale; essa ci permette di onorare il tempo del cambiamento. Essendo una forma di saggezza, la pazienza ci invita a non coltivare pretese distorte nei confronti del nostro corpo, della nostra mente e delle circostanze esterne, ci ricorda che ogni cosa ha il suo tempo per svilupparsi e maturare e che affrettare le cose, porta a risultati dannosi o indesiderati. La pazienza non è una forma di passività o di pigra inerzia quanto piuttosto un'apertura lieve che presuppone di accogliere l’esperienza del momento così come è senza cercare di forzarla o manipolarla per ottenerne subito qualcosa. Coltivare la pazienza significa essere disposti ad attendere, osservare… a permettere che le cose si dispieghino naturalmente, con i loro tempi, senza la fretta o l'ansia di dover controllare il processo continuamente. Nella pratica meditativa, la pazienza si manifesta come la capacità di rimanere presenti con le proprie sensazioni, anche se sono spiacevoli o difficili, senza cercare di evitarle, modificarle, controllarle o allontanarle. Si tratta di un'accettazione profonda del processo di crescita, sapendo che la trasformazione interiore richiede tempo, impegno e una buona dose di compassione verso se stessi.
3. Mente del Principiante: l’arte di coltivare la meraviglia
Jon Kabat-Zinn sottolinea che, per cogliere appieno la ricchezza, la pienezza e la novità del momento presente, è necessario coltivare la "mente del principiante". Questo atteggiamento interiore indica la capacità di guardare alle cose come se le vedessimo per la prima volta, senza dare nulla per scontato, senza chiudersi in schemi di pensiero, interpretazione o di percezione preconfezionati. La "mente del principiante" infatti è una mente sempre fresca come un giardino all’alba, aperta, curiosa e non giudicante; queste attitudini permettono di liberarsi dalle aspettative basate su esperienze passate, per accogliere ogni momento con freschezza e meraviglia. Spesso, tendiamo ad affrontare le situazioni con "l'atteggiamento dell'esperto" ossia pensando di sapere già cosa succederà o cosa dovremmo fare perché ci basiamo esclusivamente sulle esperienze pregresse, ma in tal modo rischiamo di riportare continuamente il passato nel presente; tale atteggiamento ci chiude alla possibilità di nuove scoperte e di nuove prospettive. Restare aperti e freschi coltivando la "mente del principiante", al contrario, ci invita a lasciare cadere le nostre certezze e a rimanere aperti a ciò che si presenta, anche se ci sembra familiare o banale. Dobbiamo ricordare che ogni momento è unico e irripetibile e coltivare la "mente del principiante" ci permette di apprezzarlo appieno.
4. Fiducia.
La fiducia è un elemento fondamentale per l'approccio e l'apprendimento della mindfulness; in questo contesto, indica la capacità di legittimarsi e fidarsi della propria esperienza, delle proprie sensazioni e della propria intuizione. Significa credere nella propria capacità di comprendere e gestire le emozioni senza dover dipendere dall'approvazione o dalla guida degli altri. Questa fiducia non è arroganza o presunzione, ma piuttosto una profonda accettazione di sé e una consapevolezza radicale del proprio valore intrinseco. Quando coltiviamo la fiducia in noi stessi, impariamo ad ascoltare la nostra voce interiore, a fidarci del nostro giudizio, del processo, e a seguire il nostro cammino autentico. La pratica della mindfulness ci aiuta a sviluppare questa fiducia, incoraggiandoci ad ascoltare attentamente il nostro corpo e la nostra mente, a riconoscere i nostri bisogni e a prenderci cura di noi stessi. Imparare a fidarci di noi stessi facilita anche la fiducia negli altri e la radicale fiducia nel processo di cambiamento e continua impermanenza che sottende tutti i fenomeni, e ci rende possibile stabilire relazioni più autentiche, basate sull’espressione di sé e sul rispetto reciproco.
5. Non Cercare Risultati: libertà nel processo.
Nella maggior parte delle nostre attività, siamo guidati da un obiettivo, da un desiderio, dalla spinta a muoverci per raggiungere un risultato specifico; la mindfulness tuttavia ci insegna qualcosa di profondamente diverso, e si distingue per il suo approccio non orientato al risultato. Sebbene la pratica richieda impegno, costanza ed intenzione, l'obiettivo non è quello di "fare" qualcosa, quanto piuttosto quello di "essere": essere pienamente consapevoli e presenti nel qui ed ora. Questo significa prestare attenzione a ciò che accade internamente ed esternamente, alle più piccole cose, senza cercare di cambiare né controllare nulla di ciò che è. Ad esempio, se ci sentiamo tesi, non cerchiamo di rilassarci immediatamente, ma ci prendiamo il tempo e la curiosità aperta di OSSERVARE la tensione, esplorandone le caratteristiche somatiche ed emotive, e le sensazioni ed i pensieri che vi si associano. Disimpariamo il cercare e coltiviamo l’esplorare ed il conoscere. Paradossalmente, è proprio il non cercare risultati che ci permette di ottenere i benefici più profondi dalla meditazione. Quando smettiamo di sforzarci e di controllare infatti, e lasciamo che “il presente accada”, ci apriamo alla possibilità di nuove scoperte e di una maggiore comprensione di noi stessi. Con la pratica costante, i risultati arriveranno naturalmente, come un effetto collaterale della nostra presenza consapevole.
6. Accettazione: le cose sono come sono.
L'accettazione è un concetto fondamentale nella pratica della mindfulness, ma dobbiamo distinguerlo con attenzione dalla rassegnazione passiva, o dalla sottomissione agli eventi o alle persone. L’accettazione di cui si parla nel contesto della MIndfulness indica una disposizione d’animo e di atteggiamento che vuole VEDERE le cose così come sono, senza giudicarle o cercare di negarle, evitarle o cambiarle. L'accettazione non implica approvazione o condono, ma un riconoscimento lucido e imparziale della realtà, richiede e ci aiuta a diventare equanimi. Spesso, nelle nostre vite quotidiane siamo abituati ad opporci anche molto duramente alla realtà, desiderando che le cose siano diverse da come sono, magari applicando forzature o sentendoci sbagliati, disperati, “falliti”, o molto arrabbiati. Questa resistenza crea tensione, sofferenza e frustrazione; l'accettazione, al contrario, ci permette di liberarci da questa resistenza e di affrontare le sfide della vita con maggiore equanimità e saggezza. Accettare non significa rinunciare ai propri bisogni o obiettivi, ma piuttosto riconoscere che in questo momento le cose sono come sono, accogliendo la consapevolezza che anch’esse - come tutti i fenomeni - muteranno: le emozioni, i pensieri e le sensazioni sono lì e le possiamo accogliere senza bisogno di giudicarle o combatterle. Questo ci permette di fermarci, osservare ed agire in modo più consapevole e appropriato. L'accettazione è il presupposto fondamentale del cambiamento. Solo quando accettiamo noi stessi e la nostra situazione attuale possiamo iniziare a trasformarla in modo autentico e duraturo.
7. Lasciare Andare: l’arte di mollare la presa.
La pratica della mindfulness ci insegna a "lasciare andare" i pensieri, le emozioni e le sensazioni che la nostra mente tende a trattenere per rimuginarci su. Questo non significa sopprimere o negare le nostre esperienze, ma piuttosto riconoscere che sono transitorie e impermanenti. La nostra mente trascorre molto tempo nel coltivare pensieri, ricordi, preoccupazioni e fantasie che ci distraggono dal momento presente tirandoci verso il passato e verso un futuro che verrà (o non verrà), in tal modo inducendo emozioni e sensazioni fisiche più o meno piacevoli, ed impedendoci di sperimentare la realtà del momento in modo diretto e senza filtro. Questi pensieri possono essere piacevoli o spiacevoli, ma in entrambi i casi tendono a catturare la nostra attenzione e a tenerci intrappolati in un ciclo di rimuginio e di preoccupazione. Imparare a "lasciare andare", a mollare la presa, significa riconoscere queste dinamiche e questi fenomeni (pensieri, sentimenti, aspettative, giudizi ecc…) peer quello che sono: fenomeni passeggeri, senza giudizio, per poi lasciarli scivolare nel flusso degli eventi delicatamente, come nuvole che passano nel cielo. Li osserviamo salire e decrescere, andare e venire…fermarsi… sorgere e tramontare nella coscienza. Questo non significa che non possiamo pensare o sentire, ma che non dobbiamo aggrapparci ai nostri pensieri e sentimenti, né identificarci con essi. Il "lasciare andare" è una forma di accettazione del momento presente, una liberazione dalla presa della mente, che per sua natura vuole controllare, spiegarsi e prevedere, e un invito a vivere pienamente l’esperienza del momento.
CONCLUSIONE
In sintesi, i 7 pilastri della mindfulness, lungi dall'essere elementi isolati, si configurano piuttosto come un sistema interconnesso e sinergico si atteggiamenti. Il Non Giudizio funge da fondamento, creando uno spazio sicuro per l'osservazione imparziale dell'esperienza, aprendo la strada alla Pazienza che permette di onorare i tempi naturali del cambiamento senza forzature. La Mente del Principiante alimenta la freschezza e la curiosità, liberandoci dalle catene delle aspettative e dei preconcetti. La Fiducia in sé stessi e nel processo emerge dall'ascolto interiore, rafforzando la capacità di navigare l'esperienza con autenticità e coraggio. Il Non Cercare Risultati ci aiuta a spostare il focus dall'obiettivo al processo stesso, permettendo di assaporare appieno ogni momento che si sussegue. L'Accettazione, infine, non è rassegnazione bensì un lucido riconoscimento della realtà così com'è, un prerequisito essenziale per il Lasciare Andare ciò che non possiamo controllare, permettendoci di fluire con l'impermanenza della vita. Insieme, questi sette pilastri costituiscono una guida preziosa per coltivare una pratica di mindfulness autentica e trasformativa, aprendo la porta a una maggiore consapevolezza, accettazione e benessere nella nostra vita quotidiana.
Vuoi imparare ad applicare la mindfulness non solo nella meditazione ma anche nella tua vita quotidiana? Contattami per un percorso personalizzato e condividi questo articolo con chi pensi possa averne bisogno.
LA TIRANNIA DELLA POSITIVITÀ:quando la positività diventa tossica
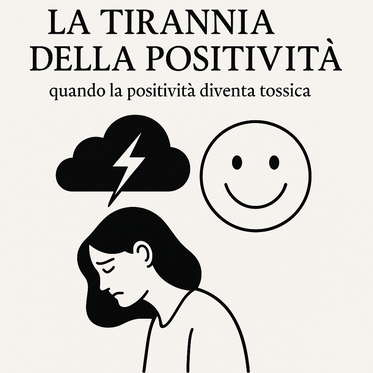
Scritto da: Annalisa Barbier
Negli ultimi anni, la “cultura della positività" ha guadagnato terreno, diventando quasi un mantra nel nostro quotidiano. Frasi come "pensa positivo" e "sii felice" sono diventate comuni e le assorbiamo senza nemmeno rifletterci su. Ma cosa succede quando questa spinta incessante verso il benessere inizia a diventare un problema?
PERCHÉ FA MALE REPRIMERE LE EMOZIONI NEGATIVE
L'idea che si debba sempre e a tutti i costi essere felici, ottimisti, positivi e costruttivi rischia di produrre un effetto collaterale a mio avviso molto grave: può indurci a credere che sia giusto, possibile e anzi doveroso rifiutare e silenziare le nostre emozioni considerate “negative” come ad esempio tristezza, rabbia o frustrazione, portandoci a giudicare noi stessi in modo duro per sentirci “giù”, vulnerabili o arrabbiati. Purtroppo, proprio questo giudizio porterà con sé un sentimento crescente di inadeguatezza, a coltivare la convinzione di avere “qualcosa che non va”, di non andar bene.
Questo fenomeno merita dunque una riflessione approfondita.
ORIGINI DELLA “RETORICA DELLA POSITIVITÀ”
La cultura della positività ha radici profonde nella filosofia occidentale, ma ha preso piede in modo particolare con il movimento del “self-help” degli anni '90 e 2000. Autori come Dale Carnegie ad esempio, nel suo libro “Come trattare gli altri e farseli amici” hanno enfatizzato l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo per ottenere successo e felicità. Tuttavia, il crescente interesse per la psicologia positiva, rappresentato da personalità come Martin Seligman, ha contribuito ulteriormente a diffondere l'idea che la felicità sia un obiettivo primario nella vita. Questa idea in sé non è affatto sbagliata, in ultima analisi, ma può diventare profondamente controversa se viene interpretata in maniera superficiale.
Sebbene la psicologia positiva abbia portato alla luce aspetti molto importanti per il benessere psicofisico - come i concetti di resilienza e ottimismo - essa ha anche indirettamente instillato l'idea che l'unico modo per vivere una vita soddisfacente sia quello di evitare qualsiasi forma di disagio emotivo.
La pressione a essere sempre felici può manifestarsi in vari ambiti della vita:
Socialmente, vengono trasmesse aspettative implicite che ci spingono a mostrare solo emozioni positive, creando un ambiente in cui la vulnerabilità, la compassione, l’empatia vengono purtroppo percepite come una pericolosa forma di debolezza. Questo fenomeno è stato descritto da Brené Brown nel suo libro “Osare in grande”, in cui l’autrice sottolinea come la cultura della vulnerabilità sia spesso soffocata dalla pressione alla “positività a tutti i costi”, e quanto sia importante tornare ad avere il coraggio della propria vulnerabilità, inevitabile aspetto della nostra comune umanità.
Come accennato, a livello individuale la spinta alla positività può condurre a una forma di auto-sabotaggio: le persone che si sentono tristi, insoddisfatte o ansiose possono sentirsi in colpa per provare queste emozioni, e agire dunque nella direzione di delegittimare, negare e finanche sopprimere i propri sentimenti più profondi e autentici. Ma la negazione delle emozioni difficili ci impone un prezzo molto alto: interferisce fino a compromettere l’espressione piena di sé, la crescita personale e l'elaborazione dei traumi.
Lo psicologo Richard Lazarus ha sottolineato come le emozioni negative possano svolgere un ruolo molto importante nel nostro processo di adattamento e di apprendimento: possono spingerci - se interpretate come segnali di orientamento nella vita - a sviluppare competenze e strategie di fronteggiamento nuove e funzionali, e dunque a costruire un benessere che nasce dalla capacità di sentirci capaci, e in grado di affrontare in qualche modo le difficoltà e i momenti difficili.
CONSEGUENZE PSICOLOGICHE
La delegittimazione delle emozioni negative può avere un impatto significativo sulla salute mentale, come evidenziato da vari studi. Ecco alcuni aspetti chiave:
- Susan David, autrice del libro “Agilità emotiva”, evidenzia come la repressione delle emozioni negative possa provocare indirettamente problemi di salute mentale, inclusi ansia e depressione, suggerendo che accettare e confrontarsi con le proprie emozioni negative è essenziale per il benessere psicologico, e che la vera resilienza si costruisce attraverso l’accettazione, non la negazione. Mi preme qui specificare che, quando si parla di “ACCETTAZIONE”, non ci si riferisce ad un atteggiamento di passiva rassegnazione quanto piuttosto ad un atteggiamento interiore, più complesso e profondo, molto simile all’Accettazione di cui si parla nella Mindfulness (in effetti è uno dei 7 pilastri della mindfulness): riconoscere e accettare che le cose sono come sono nel momento presente, in modo non giudicante, spazioso ed aperto. Significa essere pienamente presenti nelle cose, così come si presentano momento dopo momento, sospendendo qualsiasi guerra interiore basata su critiche e giudizi di “come le cose dovrebbero essere”. Questo approccio aiuta a ridurre la resistenza e il conflitto interiore, promuovendo una relazione più sana con le esperienze. Accettare ciò che è, piuttosto che combatterlo, favorisce la serenità e la crescita personale, e soprattutto ci permette di trovare strategie di fronteggiamento funzionali. inoltre ricordiamolo: le cose sono in continuo mutamento, dunque anche i momenti difficili sono destinati a passare oltre se glielo permettiamo, se non li tratteniamo tra le maglie strette della nostra resistenza.
- Ignorare o sopprimere le emozioni considerate indesiderabili o negative può impedire il corretto processamento delle esperienze.
- Negare le emozioni difficili può anche influenzare le relazioni interpersonali: un ambiente in cui si accolgono e si accettano solo emozioni positive può portare ad una mancanza di autenticità nelle interazioni tra le persone, rendendo difficile la comunicazione e la connessione emotiva, e inducendo gradualmente profondi sentimenti di disconnessione, sfiducia e isolamento.
- La resilienza non si costruisce solo attraverso esperienze positive, ma anche attraverso l'elaborazione delle emozioni dolorose; sopprimere ed evitare questi sentimenti, nel tempo riduce la nostra capacità di affrontare le difficoltà, di costruire competenze e capacità di fronteggiamento e quindi di poterci adattare in modo funzionale agli inevitabili alti e bassi della vita.
- Sopprimere, delegittimare e allontanare a tutti i costi l’esperienza delle emozioni difficili o “negative”, non influisce soltanto sulla salute mentale ma anche su quella fisica: studi hanno dimostrato che lo stress cronico e la repressione emotiva possono contribuire a problemi di salute come malattie cardiache, disturbi gastrointestinali e altre condizioni correlate.
- Un ambiente lavorativo eccessivamente votato alla “positività tossica”, può generare un clima di scarsa autenticità e comunicazione tra le persone: un articolo pubblicato sulla “Harvard Business Review” nel febbraio di quest’anno, evidenzia come la pressione a mantenere un atteggiamento positivo possa ridurre la creatività e la capacità di affrontare i conflitti, elementi essenziali per il team building e il problem solving.
CONCLUSIONE
La negazione e la repressione delle cosiddette “emozioni negative”, possono generare un circolo vizioso che compromette la salute mentale e fisica; diventa dunque cruciale imparare ad affrontare e accettare le emozioni difficili per ciò che sono: messaggeri che ci aiutano a comprendere il mondo e noi stessi, al fine di realizzare la pienezza di ciò che siamo, di avere un contatto autentico e profondo con il qui-ed-ora e con le persone intorno a noi. Come le emozioni piacevoli, anche quelle dolorose ci possono aiutare a creare legami e connessione con gli altri. accoglierle, imparare a “navigarle” attribuendo loro il giusto senso e la giusta prospettiva, è importante per coltivare il benessere psicofisico e una vita soddisfacente. La spinta alla positività, sebbene benintenzionata, può creare una "positività tossica" che ci allontana dalla nostra umanità. Riconoscere il valore di tutte le emozioni, comprese quelle negative, è fondamentale: legittimarle non significa arrendersi, ma vivere in modo autentico e completo. Solo così possiamo crescere e realizzarci pienamente come individui.
Oltre la negazione della sofferenza: la via gentile della Self Compassion

Scritto da: Annalisa Barbier
Il filosofo contemporaneo Byung-Chul Han, nel suo saggio “La società senza dolore”, ci ricorda che viviamo in una cultura e in una società in cui l’esperienza del tocco che cura e che guarisce – il sentirsi toccati, accolti e interpellati dall’Altro – è diventata sempre più rara. Solitudine, narcisismo, competizione, autosfruttamento, espulsione della negatività e perdita di solidarietà creano dolorose fratture nel tessuto sociale e dunque nella trama di senso individuale, originando e amplificando un dolore che -privato del significato che lo narra come naturale risposta ad un contesto isolante e frammentato - e’ destinato a restare individuale, ad essere considerato sbagliato e inopportuno, sintomo insomma di disfunzionalita.
In questo scenario, i dolori cronici - soprattutto quelli dell’anima - non sono soltanto un fatto medico, ma soprattutto un sintomo socio-culturale: il corpo - e con esso l’anima - si fanno portavoce di quella richiesta di vicinanza, di amore e di attenzione che non trova spazio in una società guidata dalla sfiducia e dall’individualismo. Il filosofo Han sottolinea come nessun analgesico possa sostituirsi alla scena primordiale di guarigione: quel tocco dell’altro che è esperienza viscerale di accoglienza, cura e contenimento. È proprio quella mano- amorevole e guaritrice- il gesto relazionale e corporeo che restituisce al dolore una cornice di senso, rendendolo in qualche modo sopportabile.
Ed è proprio qui, in questa terra di mezzo, che si allunga un ponte e si apre il dialogo tra il dolore vissuto nella solitudine della negatività inaccolta, e il potere della compassione.
La self-compassion come “fai da te” del tocco lenitivo
La self-compassion rappresenta allora (nella sua versione divulgativa e semplificata) una sorta di “kit di emergenza” autosomministrato. I suoi insegnamenti e le sue pratiche permettono di offrire a se stessi quel tocco lenitivo che la società e le relazioni spesso negano, incapaci sempre più di legittimare una reale apertura verso l’Altro da sé (anche il dolore viene relegato ad esperienza di “altro-da-sé”). Non elimina il bisogno dell’altro, non sostituisce l’esperienza incarnata della cura relazionale, ma diventa:
- un ponte temporaneo, che ci permette di non soccombere al vuoto di senso di cui soffre il dolore nella nostra cultura, e alla disconnessione relazionale;
- una nuova memoria corporea, che rievoca dentro di noi, letteralmente “nel corpo” l’esperienza di essere accolti e contenuti;
- una cura verso di sé Auto-somministrata, che ci consente di accogliere e consolare il nostro dolore con quelle parole e quel tocco, gentili e accoglienti, che non riceviamo dall’altro;
- riporta a se stessi il ruolo della presenza dell’altro: l’altro diventiamo noi.
In altre parole, la self-compassion legittima il dolore, lo riconosce e lo rende abitabile, creando uno spazio di presenza proprio là dove la società tende invece a silenziarlo, esiliarlo nella disfunzionalità e medicalizzarlo.
Il paradosso dell’autoreferenzialità
Certo, la self-compassion porta con sé un limite intrinseco: è autoreferenziale. Nel toccarci - metaforicamente e fisicamente - siamo allo stesso tempo l’afflitto e il guaritore, chi soffre e chi consola. Potrebbe sembrare un surrogato fragile, incapace di sostituire davvero la mano dell’altro; eppure proprio in questa apparente limitazione risiede la sua forza:
- ci permette di mantenere vivo il gesto del “prendersi cura”, anche in assenza dell’altro;
- ci offre una base di sicurezza interiore - psicologica, neurovegetativa e somatica - che non cancella ma prepara il terreno per futuri incontri relazionali;
- trasforma il dolore in testimone della nostra vulnerabilità condivisa, ricordandoci del continuo dialogo esistente tra la dimensione individuale e quella universale.
La self-compassion è, dunque, insieme stimolo alla memoria e anticipazione: ricorda al corpo la scena primordiale della cura e, allo stesso tempo, lo prepara all’apertura all’altro, alla sua ricerca, alla sua accoglienza. Non vuole cancellare la ferita, ma sa lenirla e soffiare lieve su di essa, le dona una storia e con questa un senso. Non sostituisce l’altro, ma ne tiene vivo il ricordo e il desiderio. È un modo per non lasciare che il dolore resti un grido muto, ma possa farsi narrazione ricca di senso: un messaggio ascoltato e accolto, almeno da noi stessi.
In un mondo in cui il dolore, per dirla con Han, appare “svuotato di senso” e la buona vita è ridotta a “nuda sopravvivenza”, la Compassione (nei suoi tre flussi) si fa subito atteggiamento e gesto sovversivo: una delicata e potente forma di opposizione alla negazione del dolore, alla riduzione di senso e alla frammentazione sociale che ciò comporta.
Annalisa Barbier, PhD
Psicologa, Dottore di Ricerca in Neuropsicologia
Approccio Cognitivo Comportamentale- Cognitivo Interpersonale
Compassion Focused Therapist
Conduttore protocolli MBCT
Istruttore di protocolli MBSR
Iscrizione all’Albo Psicologi del Lazio N. 9423/2000
Istruttore di Protocolli Mindfulness certificato Federmindfulness
Iscrizione all’Albo Nazionale N. 1505
www.federmindfulness.it



CONTATTAMI
Per prenotare un appuntamento ON-LINE o presso lo studio di Roma, scrivimi al 3934191174 o compila il modulo di contatto.