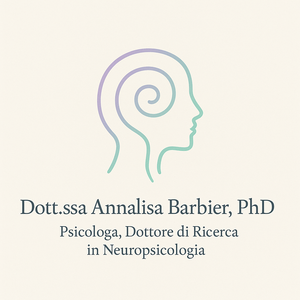TRAUMA SEMPLICE O PTSD

Breve storia della diagnosi
Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) è stato formalmente riconosciuto nel 1980, con l’inserimento nel manuale diagnostico e statistico DSM-III (American Psychiatric Association, APA). Questo riconoscimento rappresentò una svolta significativa: per la prima volta veniva riconosciuta la sofferenza psichica come conseguenza diretta di esperienze traumatiche estreme. Già dopo la Prima Guerra Mondiale si parlava di “shell shock”, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale la complessa condizione post traumatica veniva descritta come “battle fatigue” o “war neurosis”; termini che sottolineavano in modo particolare gli effetti devastanti sull’individuo del trauma bellico, ma la comprensione clinica di tale sindrome era ancora limitata.
Negli anni ’70, il movimento dei veterani della guerra del Vietnam e delle vittime di violenza spinse la comunità scientifica a riconoscere la necessità di creare una categoria diagnostica specifica per l’insieme di disturbi psichici, somatici e relazionali tipici del PTSD. Da allora, il concetto di PTSD è andato progressivamente ampliandosi, fino ad includere i traumi interpersonali (abusi, violenze domestiche), gli esiti di catastrofi naturali, di incidenti e di altre esperienze che mettono a rischio l’integrità fisica e psicologica della persona, sottolineando l’importanza della percezione di minaccia alla propria vita e di impotenza nel farvi fronte.
Negli ultimi decenni, un vasto corpo di ricerche ha dimostrato che il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) non può essere concettualizzato come la semplice “reazione psicologica” ad un evento traumatico; si tratta piuttosto di un disturbo neurobiologico e psiconeuroendocrino complesso che interessa molteplici sistemi, producendo alterazioni persistenti sul funzionamento cerebrale, sulla regolazione neurovegetativa dello stress e a carico della sfera relazionale.
1. Cervello e memoria
Gli studi di neuroimaging funzionale e strutturale hanno evidenziato una triade di alterazioni tipiche a carico di:
Amigdala: iperattivata, con un ruolo centrale nell’iperarousal e nella facilità di innesco delle risposte di paura. È responsabile dell’iper-reattività agli stimoli, che vengono percepiti facilmente come minacciosi, e della persistenza delle memorie emotive traumatiche.
Ippocampo: ridotto in volume e ipoattivo. La sua disfunzione compromette la capacità di collocare i ricordi traumatici nel tempo e nello spazio (deficit di contestualizzazione spazio-temporale), favorendo intrusioni di frammenti di memoria e flashback.
Corteccia prefrontale mediale (mPFC): ipoattiva, con minore capacità di modulare l’attività dell’amigdala; tale ipoattivazione riduce la capacità di controllo top-down sulle risposte emotive e sullo stress. Questa combinazione di alterazioni riscontrate spiega perché i ricordi traumatici abbiano una qualità sensoriale, frammentata e sopraffacente, e perché il paziente sperimenti il trauma come “presente e rivissuto” nel qui ed ora.
2. Neurobiologia
Un altro aspetto centrale è la disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (asse HPA):
Nei soggetti con PTSD si osservano spesso livelli più bassi di cortisolo basale associati ad un’aumentata sensibilità dei recettori glucocorticoidi, presentando una risposta di stress paradossalmente inefficace e instabile. Parallelamente, è documentata una iperattivazione del sistema noradrenergico (locus coeruleus e vie adrenergiche), che sostiene ipervigilanza, insonnia, risposte di allarme esagerate e un’attivazione ansiosa cronica. Tale squilibrio tra ipo-reattività cortisolemica e iperattività noradrenergica rende conto della persistenza dei sintomi anche in assenza di trigger traumatici diretti.
3. Circuiti della memoria
Le memorie traumatiche si consolidano in modo anomalo: prevalgono le componenti implicite, sensoriali e corporee, che restano scollegate dalle componenti esplicite e narrative. Ciò produce ricordi frammentati, intrusivi e scarsamente contestualizzati, che emergono sotto forma di flashback o reazioni corporee intense. L’alterata integrazione tra ippocampo e corteccia prefrontale impedisce al cervello di riconoscere l’esperienza come “passata”, mantenendo la sensazione che il trauma stia ancora accadendo nel presente.
4. Neuroscienze sociali
Il trauma non colpisce solo il funzionamento individuale, ma anche la capacità di stabilire legami sicuri e relazioni autentiche e durature; secondo la teoria polivagale di Stephen Porges, il PTSD comporta una compromissione di quello che viene definito “sistema di ingaggio sociale”, che provoca:
- ridotta capacità di autoregolazione fisiologica tramite l’attivazione del nervo vago nella sua sezione ventrale;
- difficoltà a percepire l’altro come sicuro (neurocezione negativa), con conseguente evitamento, diffidenza e isolamento relazionale.
Queste alterazioni spiegano l’impatto del disturbo sul funzionamento interpersonale e sulle relazioni di attaccamento.
5. Fattori genetici ed epigenetici
Gli studi di genetica molecolare ed epigenetica hanno mostrato che varianti geniche come FKBP5 (coinvolto nella regolazione dei recettori glucocorticoidi) e SLC6A4 (trasportatore della serotonina) aumentano la vulnerabilità al PTSD, e che l’esposizione precoce a traumi infantili può modificare l’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici (es. metilazione del DNA), predisponendo ad una maggiore reattività allo stress e dunque ad un rischio maggiore di sviluppare il PTSD in età adulta.
Queste evidenze dimostrano che il PTSD è un disturbo multisistemico, nel quale interagiscono alterazioni neurobiologiche, neuroendocrine, cognitive e relazionali. Non può quindi essere compreso né trattato esclusivamente come un problema psicologico: richiede approcci terapeutici integrati, capaci di intervenire sia sui processi mentali che sui meccanismi corporei e relazionali che mantengono la sofferenza.
CRITERI DIAGNOSTICI
DSM-5 (APA, 2013)
Il PTSD è classificato tra i Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti. La diagnosi di questa condizione richiede:
- Criterio A: Esposizione al trauma in forma di esposizione diretta, testimonianza, apprendimento di un evento traumatico accaduto a persone care, o esposizione ripetuta a dettagli traumatici (es. soccorritori).
- Criterio B: Presenza di sintomi intrusivi (almeno 1) come ricordi intrusivi e involontari, incubi ricorrenti legati al trauma, flashback, reazioni psicologiche intense a stimoli associati al trauma, reazioni fisiologiche marcate agli stimoli correlati.
- Criterio C: Evitamento persistente (almeno 1) di ricordi, pensieri, emozioni legati al trauma; evitamento di luoghi, persone, attività o situazioni associate.
- Criterio D: Alterazioni negative di cognizioni e umore (almeno 2) come amnesia dissociativa, convinzioni negative persistenti su sé, altri o il mondo, autoaccuse eccessive, emozioni negative pervasive, anedonia e distacco dagli altri, incapacità di provare emozioni positive.
- Criterio E: Alterazioni dell’arousal e della reattività (almeno 2) come irritabilità, comportamenti autodistruttivi, ipervigilanza, risposta di allarme esagerata, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno.
- Criterio F: durata dei sintomi >1 mese.
- Criterio G: compromissione significativa del funzionamento.
- Criterio H: i sintomi non sono attribuibili all’uso di sostanze o ad altre condizioni mediche. Specifiche: con sintomi dissociativi (depersonalizzazione/derealizzazione); con esordio ritardato.
ICD-11 (OMS, 2018)
L’ICD-11 semplifica i criteri, proponendo un modello basato su tre cluster sintomatici principali:
- Rivivere il trauma: ricordi intrusivi, flashback, incubi angoscianti.
- Evitamento: di pensieri, ricordi, situazioni o persone collegate al trauma.
- Percezione di minaccia persistente: ipervigilanza, reazioni di allarme esagerate.
Per la diagnosi è necessaria la presenza di tutti e tre i cluster. L’ICD-11 sottolinea la distinzione tra PTSD e C-PTSD.
PREVALENZA
Il Disturbo da Stress Post-Traumatico non è una condizione rara: le indagini epidemiologiche internazionali mostrano che circa il 3,9% della popolazione generale sviluppa un PTSD in seguito all’esposizione a eventi traumatici (Kessler et al., 2017). Se consideriamo l’intero arco di vita, la prevalenza stimata del disturbo si colloca tra il 5% e l’8%. Il disturbo colpisce più frequentemente le donne, che presentano un rischio quasi doppio rispetto agli uomini; tale differenza è in parte spiegata dalla più elevata esposizione femminile a traumi interpersonali quali violenza sessuale e violenza domestica. I traumi inflitti da altre persone o traumi relazionali - soprattutto se avvengono in contesti di fiducia o in età precoce - hanno un impatto più duraturo e complesso rispetto ai traumi accidentali o naturali. E’ importante sottolineare che, nonostante molte persone vengano esposte a eventi traumatici, solamente una parte di esse sviluppa il disturbo: ciò mette in evidenza l’importanza dei fattori di resilienza, come il supporto della rete sociale e relazionale, la capacità di regolazione emotiva individuale (a sua volta spesso legata alla storia di attaccamento) e la possibilità di accedere tempestivamente ad aiuto e cure.
COMORBIDITA’ E DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Il PTSD raramente si presenta in forma pura; molto più frequentemente infatti esso si accompagna ad altri disturbi psicologici, e tra le comorbidità più comuni troviamo:
- depressione maggiore, che può derivare dalla perdita di speranza e dal senso di colpa tipicamente sperimentati nel disturbo post traumatico
- disturbi d’ansia, caratterizzati da ipervigilanza e stati di tensione costante
- abuso di sostanze, spesso utilizzate come tentativo disfunzionale di curare e ridurre i sintomi intrusivi
- Disturbi dissociativi, soprattutto presenti nelle forme gravi o complesse, come il Disturbo di Depersonalizzazione (sensazione di essere distaccato dal proprio corpo), di derealizzazione in cui la persona percepisce il mondo esterno come irreale, l’Amnesia Dissociativa ossia l’incapacità di ricordare aspetti importanti del trauma e, in alcuni casi gravi soprattutto di traumi infantili ripetuti, il Disturbo Dissociativo dell’Identità (DDI) con la presenza di più stati del Sé dissociati tra di loro. In clinica, si parla di “sottotipo dissociativo di PTSD” (DSM-5), caratterizzato proprio da sintomi persistenti di depersonalizzazione e derealizzazione.
La diagnosi differenziale dunque richiede particolare attenzione e possiamo sinteticamente ricordare alcune differenze importanti: nella depressione maggiore l’umore depresso e l’anedonia sono centrali, ma mancano le intrusioni di memorie traumatiche; nei disturbi d’ansia, la paura è diffusa e non appare legata a ricordi traumatici specifici; nel Disturbo Ossessivo Compulsivo - DOC, i pensieri intrusivi hanno natura egodistonica e sono spesso seguiti da rituali compulsivi, mentre nel PTSD si tratta dell’emergenza intrusiva di memorie traumatiche; nei disturbi dissociativi, sintomi come depersonalizzazione e derealizzazione possono sovrapporsi, ma nel PTSD sono risposte di sopravvivenza collegate al vissuto traumatico; infine, nelle psicosi i flashback possono essere confusi con le allucinazioni, ma differiscono per la qualità specifica di contenuto e modalità di insorgenza.
La valutazione diagnostica del PTSD richiede dunque una ricostruzione accurata della
storia del paziente e dell’eventuale esposizione ad eventi traumatizzanti, ed una sensibilità clinica capace di distinguere tra sintomi apparentemente simili, sebbene di origine diversa.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). APA.
- World Health Organization (2018). International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11). WHO.
- Van der Kolk, B. (2015). Il corpo accusa il colpo. Milano: Raffaello Cortina.
- Herman, J. L. (1992). Trauma and Recovery. Basic Books.
- Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., et al. (2017). Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. European Journal of Psychotraumatology, 8(sup5): 1353383.
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2013). Evidence for
proposed ICD-11 PTSD and Complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 4: 20706.
- Yehuda, R., & McFarlane, A. C. (1995). Conflict between current knowledge about PTSD and its original conceptual basis. American Journal of Psychiatry, 152(12), 1705–1713.
Annalisa Barbier, PhD
Psicologa, Dottore di Ricerca in Neuropsicologia
Approccio Cognitivo Comportamentale- Cognitivo Interpersonale
Compassion Focused Therapist
Conduttore protocolli MBCT
Istruttore di protocolli MBSR
Iscrizione all’Albo Psicologi del Lazio N. 9423/2000
Istruttore di Protocolli Mindfulness certificato Federmindfulness
Iscrizione all’Albo Nazionale N. 1505
www.federmindfulness.it



CONTATTAMI
Per prenotare un appuntamento ON-LINE o presso lo studio di Roma, scrivimi al 3934191174 o compila il modulo di contatto.