
Scritto da: Annalisa Barbier
Quante volte ci ritroviamo a “perdere noi stessi” in una relazione, a mettere l’altro al centro, a cercare conferme esterne e sentirci vuoti quando quelle conferme non arrivano? In molte relazioni caratterizzate da dipendenza affettiva, questo meccanismo è centrale: l’identità, l’autostima, la stabilità emotiva dipendono dall’altro, e non da un punto saldo interno.
Al contrario, essere “centrati su se stessi” significa possedere un nucleo interno di consapevolezza, forza emotiva e rispetto per la propria interiorità, vivendola come un punto sicuro da cui partire e non qualcosa da cui fuggire. È una scelta, un esercizio continuo, un modo di “abitare se stessi” anche e soprattutto in relazione con gli altri.
COSA SIGNIFICA “ESSERE CENTRATI”?
Essere centrati non significa mostrare rigidità di vedute, isolarsi, rifiutare il legame o vivere in un costante atteggiamento difensivo; al contrario, significa avere un punto di radicamento interiore che consente di abitare se stessi con stabilità e presenza, senza annullarsi o farsi travolgere dalle dinamiche esterne. È un modo di stare nel mondo che permette di coltivare relazioni più autentiche, perché non basate sulla paura, sul bisogno compulsivo o sulla fusione, ma sulla libertà e sulla scelta consapevole. Vediamo nel dettaglio alcune dimensioni fondamentali che caratterizzano una persona centrata.
1. Presenza interiore e radicamento emotivo
Un aspetto importante è quello del saper “tornare a casa” in sé stesss, anche quando intorno regna la confusione. È la capacità di non perdersi nel vortice degli eventi esterni, di ritrovare un punto fermo all’interno di sé, uno spazio di osservazione e di ascolto stabile: come cantava Battiato “un centro di gravità permanente”. Questo richiede la capacità di avere consapevolezza dei propri stati interni come pensieri, emozioni, sensazioni corporee. Non si tratta di controllarli o negarli, ma di accoglierli, riconoscerli e dar loro un nome e uno spazio. Una persona centrata sa dire a se stessa: “in questo momento sento turbamento” oppure “sento la stanchezza”, “sto vivendo un sentimento di vulnerabilità”. Questa presenza gentile e attenta riduce il rischio che, nei momenti difficili, la prima reazione sia quella di cercare all’esterno — nel partner, negli amici, nelle conferme continue — una stabilità che sentiamo mancare dentro. La persona centrata coltiva un equilibrio che le permette di affrontare le onde emotive senza esserne travolta, radicandosi in un senso di presenza stabile.
2. Abilità di regolazione emotiva
Essere centrati e radicati non significa non provare emozioni intense e difficili come rabbia, dolore, paura, entusiasmo o desiderio; significa piuttosto sviluppare la capacità di modulare e regolare questi stati, accogliendoli senza esserne sopraffatti. Una persona centrata è in grado di osservare ciò che accade dentro di sé, respirare attraverso eventuali turbolenze emotive e, con gradualità, lasciare che le emozioni facciano il loro corso senza reagire in modo impulsivo, agirle all’esterno o delegare all’altro il compito di “sistemare” e calmare ciò che sente. In psicologia, questo processo si avvicina al concetto di autonomia e autoregolazione emotiva: la capacità di prendersi cura, validare e consolare i propri stati interni senza dipendere interamente da un interlocutore esterno per calmarsi o sentirsi adeguati. È un aspetto centrale per chi è incline alla dipendenza affettiva, perché interrompe il ciclo per cui il benessere dipende unicamente dalle attenzioni o dalle rassicurazioni esterne.
3. Capacità di sentire e legittimare i propri bisogni
Molte persone cresciute in contesti affettivi instabili o caratterizzati da trascuratezza emotiva hanno imparato a mettere a tacere i propri bisogni, per paura di disturbare o di perdere l’amore dell’altro. Questo si riflette nelle relazioni adulte, dove si rinuncia a chiedere, ci si adatta, ci si annulla pur di mantenere il legame. Essere centrati aiuta a ribaltare questo schema:
- Ascoltare i propri bisogni inizia dal fermarsi e chiedersi con curiosità: “Cosa sto provando in questo momento? Di cosa ho bisogno? Cosa sarebbe per me nutriente?”. Questo esercizio di consapevolezza aiuta a distinguere ciò che origina dall’autenticità del sentire profondo da ciò che nasce dalla paura e da schemi di reazione impulsivi.
- Legittimare i propri bisogni: riconoscere che i propri bisogni hanno dignità e valore, indipendentemente dal fatto che siano condivisi o riconosciuti dall’altro, è un passaggio cruciale per uscire dal circolo vizioso della svalutazione di sé.
- Esprimere bisogni e punti di vista personali con chiarezza e rispetto, senza pretendere né imporre che questi vengano accolti e soddisfatti, ma imparando a comunicarli senza colpevolizzarsi, e senza far dipendere il proprio benessere dalla qualità della risposta altrui. Ciò non vuol dire che ogni bisogno o punto di vista dovrà essere accolto e soddisfatto, tantomeno significa che l’altro sia obbligato a farlo, ma che il primo passo è riconoscerli, onorarli, e trovare modi per prendersene cura anche in autonomia.
4. Confini chiari e assertività
Essere centrati comporta la capacità di dire “sì” e “no” in modo consapevole. A questo riguardo occorre sfatare il falso mito che spesso si accompagna al timore di porre limiti e confini: il mito che considera il ritrarsi, il dire “no” come segno di egoismo. Saper mettere dei confini tra sé e l’altro è un’abilità che protegge la propria integrità. In questo modo il “sì” - quando autentico - diventa un dono libero e non un sacrificio forzato dal dover essere sempre disponibili e accondiscendenti. Nelle relazioni, questo si traduce nella capacità di stabilire confini chiari e quando l’altro chiede troppo, quando si sente che il proprio spazio mentale, emotivo o fisico è invaso, permette di saperci fermare, per affermare ciò che è accettabile e ciò che non lo è. L’assertività è la forma comunicativa che permette di esprimere con chiarezza e rispetto i propri limiti e bisogni, senza diventare aggressivi o arroganti ma senza scivolare nella passività della condiscendenza. Una persona centrata sa che proteggere il proprio spazio non è un atto di chiusura, ma di cura di sé e della relazione stessa.
5. Identità distinta
Un legame sano non richiede la fusione totale con l’altro ma l’incontro tra due identità già complete; essere centrati aiuta a custodire e mantenere viva la propria individualità coltivando interessi, passioni, amicizie, attività e progetti personali. Quando non si è centrati si tende a vivere le relazioni all’interno di una logica della “metà mancante”, in cui si cerca nell’altro la conferma continua della propria esistenza e del proprio valore. Una persona centrata, invece, riconosce di essere un individuo a sé stante, che sceglie di condividere con l’altro la propria vita senza annullarsi e questo permette alla relazione di crescere in uno spazio di libertà e autenticità reciproca.
6. Autostima ed equilibrio tra dare e ricevere
L’ultima dimensione riguarda la percezione del proprio valore: essere centrati aiuta a coltivare un’autostima che non vacilla o si esalta ad ogni sguardo o parola del partner; non si tratta di essere indifferenti al punto di vista dell’altro ma di avere un punto di riferimento interno - stabile e consapevole - che sostiene anche nei momenti di contrasto, silenzio o distanza nella relazione. Chi è centrato non basa il proprio senso di dignità soltanto su quanto riceve dall’altro ma coltiva un equilibrio tra dare e ricevere, evitando di svuotarsi o annullarsi per l’altro e di pretendere che l’altro sia l’unica fonte di nutrimento emotivo. Questo equilibrio nasce dal riconoscimento del proprio valore come indipendente dalle conferme esterne ma radicato in un senso intimo di dignità e appartenenza. In sintesi, essere centrati su se stessi significa vivere con radicamento, consapevolezza e cura verso di sé, riconoscendo che il proprio valore non è negoziabile e che i propri bisogni sono importanti almeno come quelli degli altri. Solo da questa posizione è possibile entrare nelle relazioni non come una “metà in cerca di completamento” ma come persona intera e completa, che sceglie di condividere, crescere e amare un’altra persona.
COLTIVARE STABILITÀ INTERIORE
Il percorso per sentirsi più radicati e centrati può richiedere pazienza, costanza e gentilezza verso la propria vulnerabilità. Di seguito elenco alcuni semplici suggerimenti, utili da conoscere e praticare quotidianamente.
1. Pratiche di consapevolezza e mindfulness: Dedicare ogni giorno qualche minuto a portare intenzionalmente l’attenzione al respiro, al corpo, alle sensazioni presenti e se qualcosa ci disturba, provare ad osservarlo senza giudizio: “Ecco che il mio petto si contrae”, “Ecco che c’è agitazione”. Questa pratica rafforza la capacità di disidentificarsi dai propri pensieri imparando a sentirsi “il testimone”, invece di essere colui/colei che ne viene travolto.
2. Diari interiori e auto-dialogo: Coltivare l’abitudine di scrivere un diario — anche solo in forma di brevi appunti — aiuta a chiarire quello che si sente: rabbia, paura, solitudine, desiderio... nel diario si può dare voce a bisogni che erano rimasti non riconosciuti o silenziosi, e nel descriverli si può imparare sempre meglio a conoscerli e riconoscerli; ad esempio “Vorrei che qualcuno mi ascoltasse senza giudizio”, “Mi piacerebbe avere più tempo per me”, oppure “oggi c’è stata molta tristezza per la tale ragione”… Rileggere queste righe può essere un modo per dare spazio e illuminare i bisogni interiori.
3. Riconoscere i bisogni autentici: Uno degli aspetti più delicati del processo di centratura è distinguere tra i bisogni autentici - quelli che nascono dal nostro nucleo più profondo e ci orientano verso il benessere, da quelli che invece derivano da paure, schemi disfunzionali o pressioni esterne. Non tutti i desideri che si sentono hanno infatti la stessa “qualità” interiore: alcuni ci rappresentano e ci nutrono davvero, mentre altri sono finalizzati a colmare dei vuoti, o a prevenire stati di apprensione o disagio. Ad esempio, c’è una differenza tra il bisogno genuino di vicinanza affettiva e il desiderio compulsivo di controllare costantemente il partner per paura dell’abbandono o del tradimento; nel primo caso si tratta di un’esigenza umana, sana, di contatto e intimità, ma nel secondo è la paura a guidare, e spesso porta ad avere comportamenti che compromettono la connessione e la vicinanza tra i partner, creando distanza e discussioni invece di avvicinare.
Per questo può essere utile sviluppare una sorta di “dialogo interiore di valutazione”, ponendosi alcune domande chiave:
- Questo bisogno parla del mio benessere reale o è condizionato da una paura (ad esempio la paura di perdere l’altro)? Fermarsi a riflettere su questa distinzione è fondamentale: un bisogno autentico tende a generare chiarezza e calma interiore quando lo riconosciamo, mentre un bisogno guidato dalla paura porta con sé ansia, senso di urgenza e di costrizione all’azione.
- Se pongo questo limite, rischio che l’altro non lo capisca o lo rifiuti? E se sì, sono disposta ad accettare questa possibilità pur di rimanere fedele a me stessa? Avere confini chiari non significa avere garanzia che questi che saranno sempre accolti dall’altro, ma riconoscere che sono necessari per preservare la propria integrità. L’atto di legittimare un limite, anche a costo di non essere compresi, è uno degli elementi che rafforzano la centratura interiore ed il senso di identità.
- Qual è la via intermedia? Cosa posso realisticamente chiedere all’altro e cosa posso imparare a offrirmi da sola? Non sempre l’altro può - né deve - soddisfare ogni nostro bisogno. In alcune situazioni, la strada più sana è bilanciare ciò che chiediamo all’altro con ciò che possiamo donarci autonomamente. Ad esempio, se il bisogno è di rassicurazione, posso chiederla in modo chiaro al partner, ma posso anche imparare a rassicurarmi - se tale bisogno diventa eccessivo o irrazionale - attraverso tecniche di auto-compassione, scrittura o meditazione.
Questo processo di valutazione e osservazione non deve essere confuso con la svalutazione o delegittimazione dei propri bisogni; ci permette piuttosto di accoglierli, osservarli con chiarezza e riconoscerne la qualità, ci aiuta a comprendere quali di essi vengono dal cuore della autenticità e meritano di essere ascoltati e portati nella relazione, e quali invece nascono da ferite o aspettative eccessive, che richiedono prima di tutto cura interiore. Questo discernimento non solo rafforza il senso di sé, ma contribuisce anche alla costruzione di relazioni più sane: una persona capace di distinguere e legittimare i propri bisogni autentici infatti non chiede all’altro di colmare vuoti infiniti, ma porta nella relazione autonomia, chiarezza, maturità e stabilità.
4. Allenare l’assertività e il linguaggio dei confini
Ci si può esercitare con piccoli passi: esprimere un “no” gentile ma chiaro, chiedere qualcosa che per noi è importante, negoziare un compromesso, imparare a dire “In questo momento ho bisogno di…” senza colpevolizzarsi. È normale che all’inizio il timore del conflitto sia intenso, ma l’alternativa è continuare a tacere e far crescere frustrazione e insoddisfazione.
5. Momentanea solitudine e spazio interno
Trascorrere momenti in solitudine non per punizione o isolamento ma per ritrovarsi, è un antidoto davvero molto potente alla tendenza a dipendere dagli altri. Nei momenti di “solitudine scelta” ascoltiamo, camminiamo, ci muoviamo, respiriamo, facciamo ciò che ci nutre e impariamo a dimorare dentro di noi, insieme a noi stessi. Non tutto deve essere condiviso perché l’intimità primaria, quella davvero importante per sentirsi in equilibrio, è quella che possiamo avere con noi stessi.
6. Supporto psicologico o terapeutico
Se tuttavia emergono ferite profonde — paura intensa dell’abbandono, schemi interni ripetitivi e rigidi caratterizzati da svalutazione, impulsività, sottomissione o ricordi di esperienze traumatiche — può essere importante il supporto di un professionista. Lavorare sugli schemi d’attaccamento o su pattern di dipendenza affettiva è una parte essenziale del cammino.
NELLE RELAZIONI DI DIPENDENZA
Quando una relazione è intensamente segnata da dinamiche di dipendenza affettiva, la persona “perde” se stessa e l’altro diventa un porto di approdo imprescindibile, un punto di riferimento identitario pericolosamente necessario. Trovare e coltivare costantemente la propria capacità di centratura è dunque ancora più importante e necessario, per diverse ragioni:
1. Per recuperare autonomia: nelle relazioni di dipendenza affettiva la soluzione di ogni turbamento interiore viene rimessa all’altro: “Se non mi chiama, sto male; se non mi rassicura, vado in crisi” ecc… Ma l’altro non può essere sempre presente, né può sostenere da solo tutti i nostri stati emotivi. Una persona centrata diventa capace di accogliere l’ansia, la paura, la rabbia e di averne cura anche se l’altro è distante, senza collassare.
2. Per evitare che si stabiliscano dinamiche disfunzionali e fusionali: nei rapporti codipendenti i confini si dissolvono e i ruoli si cristallizzano (chi dà, chi riceve, chi salva, chi è salvato), limitando la crescita individuale e facendo emergere spesso risentimenti, lotte sotterranee per il potere, conflitti e collusioni infantili. Il rischio è che entrambi i partner perdano la propria libertà e autenticità.
3. Per SCEGLIERE la relazione come qualcosa che arricchisca: quando si è centrati, si sceglie di restare con qualcuno non perché “non si può stare senza”, ma perché si desidera essere nella relazione con pienezza e presenza. Solo così la relazione diventa un atto di reciproca decisione e non una continua fuga dalla paura. In questo modo si costruiscono legami più autentici, relazioni all’interno delle quali ciascuno è pienamente sé, e insieme si sceglie di crescere.
4. Per riconoscere e uscire da relazioni tossiche: Quando si è centrati e radicati si ha maggiore chiarezza per poter identificare schemi manipolativi, dinamiche disfunzionali, richieste irragionevoli, controllo e comportamenti abusanti. Si hanno il coraggio e la lucidità di dire “basta”, di chiedere cambiamenti, di allontanarsi se necessario.
IL FENOMENO DI MICHELANGELO (o effetto scultore)
Uno degli aspetti più affascinanti delle relazioni mature e sane è ciò che la psicologia sociale ha definito il “Michelangelo phenomenon”, ossia la capacità dei partner di vedersi reciprocamente non solo per ciò che sono nel presente, ma anche per il potenziale che ciascuno porta con sé, e di incoraggiarsi a vicenda a diventare la versione migliore di sé stessi. Il termine si ispira al lavoro del grande scultore Michelangelo, che affermava di “liberare” la forma già presente nel blocco di marmo e non imponeva dall’esterno qualcosa di estraneo, ma rimuoveva il superfluo per permettere all’opera sottostante di emergere. Allo stesso modo, in una relazione matura fondata sul rispetto, ciascun partner sostiene l’altro non cercando di plasmarlo a propria immagine, ma aiutandolo a scoprire e valorizzare ciò che è già presente in lui o in lei, che forse non è ancora espresso o è bloccato da paure e insicurezze. Questo processo diventa possibile tuttavia solo quando entrambi i partner mantengono il proprio centro interiore, la propria autonomia senza confondersi, senza annullarsi, senza pretendere che l’altro colmi vuoti profondi che appartengono alla propria storia. Quando ciascuno dei partner custodisce la propria autonomia e identità può scegliere liberamente di essere al fianco dell’altro come specchio amorevole, fornendo sostegno e incoraggiamento. In queste condizioni, la relazione diventa un terreno fertile di crescita reciproca mentre al contrario - quando mancano centratura e autonomia - la dinamica può trasformarsi facilmente in manipolazione o controllo in cui l’altro viene forzato a diventare ciò che uno dei due desidera, in una logica di potere o di fusione disfunzionale.
Conclusione
Essere centrate su se stesse non è un privilegio riservato alle “donne forti”, ma un cammino accessibile (seppure impegnativo) per chi desidera vivere relazioni più sane, libere e autentiche. Non è un obiettivo da “raggiungere” una volta per sempre, ma un atteggiamento interiore costantemente orientato alla consapevolezza e all’individuazione. Iniziare significa accorgersi di quel primo spazio che si è perduto, di quel bisogno non ascoltato, di quel confine che non abbiamo osato tracciare, e continuare presuppone coltivare attenzione, gentilezza verso sé stesse, il coraggio di esprimere la propria autenticità interiore e di accettare che l’altro non può essere “tutto” per noi, né noi possiamo essere il tutto dell’altro.
E tu, quale piccolo passo vuoi fare per tornare ad abitare nello spazio del tuo centro?
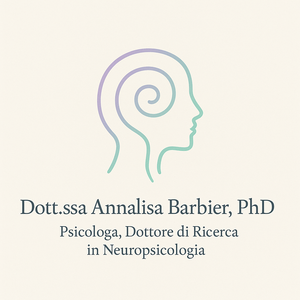



Scrivi commento