
Scritto da: Annalisa Barbier
Il termine “Preservative Cognition” (PC), che possiamo tradurre in italiano come “cognizione protettiva” viene usato in letteratura per indicare la tendenza a mantenere attiva la rappresentazione mentale di stressor passati o futuri, come ad esempio le ruminazioni su eventi passati che hanno avuto un impatto doloroso o negativo, e/o il continuo preoccuparsi (worry) su eventi spiacevoli che potrebbero accadere in futuro (anche se molti di questi spesso non accadranno mai). Il punto chiave di questo atteggiamento - naturale per la nostra mente, organizzata per proteggerci - è che induce continuamente il corpo a rimanere in uno stato di attivazione in modalità “allarme”, anche quando l’evento non c’è più o non è ancora accaduto, prolungando in tal modo l’attivazione psicofisiologica legata alla risposta di stress, e i suoi effetti sulla salute psicofisica. Questa è l’ipotesi cardine proposta da Brosschot, Gerin e Thayer nel 2006.
Le meta-analisi e le review degli studi scientifici mostrano che la PC si associa ad una attivazione del sistema cardiovascolare, del sistema neurovegetativo e del sistema endocrino (l’attivazione del sistema nervoso simpatico si traduce nell’attivazione cronica dell’asse Ipotalamo-ipofisi-corteccia surrenale o HPA, con produzione di cortisolo), ad una riduzione del tono vagale ed un recupero più lento dopo lo stress. Questo profilo di funzionamento, nel tempo, mostra di poter aumentare il rischio di sviluppare disturbi cardiometabolici; in particolare, gli studi mostrano che tale attivazione cronica prodotta dalla ripetizione di pensieri negativi e di preoccupazione, esita spesso in un funzionamento vascolare caratterizzato dall’aumento delle resistenze pressorie periferiche e da un recupero pressorio più lento: aspetti considerati rilevanti nell’indurre l’ipertensione.
HRV, cervello e autoregolazione
La Heart Rate Variability (HRV), o variabilità interbattito, è un indice psicofisiologico che misura le variazioni dell’intervallo di tempo tra un battito cardiaco e l’altro. Nonostante il cuore batta con una frequenza media, la distanza tra due battiti consecutivi non è mai identica: questa “variabilità” tra un battito e l’altro riflette la capacità del sistema nervoso autonomo di adattare la funzione cardiaca alle richieste interne ed esterne dell’organismo. Questa capacità del sistema nervoso autonomo, di restare flessibile e pronto in base alle necessità, si riflette nella possibilità di regolare lo stato di attivazione, riposo e ripresa in modo elastico e adattivo rispetto all’ambiente.
Una HRV più elevata è considerata segno di flessibilità fisiologica: indica che il sistema nervoso è in grado di modulare in modo rapido ed efficace le risposte di attivazione e di recupero. Al contrario, una HRV più bassa è indicativa di una minore capacità di regolazione e ridotta flessibilità, e si collega ad una condizione di maggior vulnerabilità allo stress, spesso associata a disturbi d’ansia, depressione e patologie cardiovascolari.
Il meccanismo centrale alla base della HRV è quello del tono vagale, ossia il livello di attività parasimpatica regolata dal nervo vago, che funziona agendo da “freno” sul cuore e sul sistema simpatico convolto nelle risposte di attacco/fuga; ciò ci significa che, quando il tono vagale è alto, il cuore può variare in modo flessibile la frequenza dei suoi battiti e l’organismo è in grado di passare più facilmente da stati di attivazione a stati di calma e recupero. Quando invece è basso, il cuore mostra maggiore “rigidità” nel variare la sua frequenza di battito e l’organismo resta più a lungo in condizioni di iperarousal (o iperattivazione simpatica) tipica delle risposte di attacco/fuga legate a paura, preoccupazione o ansia.
Questo principio è spiegato dal Neurovisceral Integration Model (NIM) di Thayer & Lane (2000), secondo cui la HRV vagale media (vmHRV) è un indicatore della conessione funzionale tra corteccia prefrontale e sistemi sottocorticali di difesa (amigdala, ipotalamo). In pratica, la vmHRV riflette in qualche modo la capacità, della corteccia prefrontale, di inibire risposte emotive e fisiologiche eccessive:
- HRV alta → maggiore controllo top-down, migliore autoregolazione emotiva e cognitiva, più resilienza allo stress.
- HRV bassa → scarso controllo, maggiore impulsività e rigidità comportamentale, vulnerabilità a stress cronico e disturbi psicosomatici.
In ambito clinico, monitorare la HRV consente di valutare la qualità della regolazione autonomica e di identificare soggetti maggiormente a rischio di disregolazione emotiva e fisiologica. Inoltre, la HRV non è solo un indicatore, ma l’importanza del ruolo che gioca nel promuovere/ostacolare il benessere psicofisico la rende anche un obiettivo terapeutico: infatti, pratiche come mindfulness, respirazione, biofeedback e pratiche di self-compassion hanno dimostrato di poter aumentare la HRV, migliorando così la capacità di autoregolazione emotiva e neurovegetativa e di ridurre i sintomi psicopatologici.
PC e HRV: cosa dice la ricerca
Negli ultimi anni numerosi studi hanno esplorato il legame tra cognizioni protettive (PC) e variabilità interbattito (HRV), confermando che i due fenomeni sono strettamente intrecciati.
Una meta-analisi pubblicata nel 2019 (Kocsel et al.,) ha evidenziato che le forme di PC che emergono mentre la persona è effettivamente immersa in processi di worry o ruminazione (PC di stato), si associano in modo significativo ad una riduzione della HRV a riposo. Questo mostra che, quando la mente rimane agganciata a pensieri ripetitivi e intrusivi, la capacità dell’organismo di mantenere un equilibrio autonomico flessibile diminuisce sensibilmente. Gli effetti relativi alla PC di tratto (cioè la predisposizione stabile a rimuginare o ruminare) invece, sono risultati meno consistenti: in altre parole, ciò che sembra incidere maggiormente sul sistema fisiologico è soprattutto l’esperienza immediata e attuale del pensiero caratterizzato da preoccupazioni sul futuro e su ruminazioni sul passato (PC).
Un studio longitudinale del 2018 (Carnevali et al.) approfondisce questa connessione, mostrando che la HRV vagale media potrebbe avere un ruolo di collegamento tra ruminazione e sintomi depressivi; lo studio ha evidenziato che i partecipanti con livelli più elevati di ruminazione mostravano, nel tempo, una HRV più bassa, la quale a sua volta era associata a un incremento dei sintomi depressivi. Questo dato sottolinea un aspetto davvero interessante e cruciale: la PC non solo contribuisce a mantenere elevato lo stress fisiologico, ma può anche costituire un meccanismo attraverso cui la vulnerabilità emotiva si traduce in psicopatologia clinica.
Nel complesso, queste ricerche suggeriscono che la HRV rappresenta un ponte neurofisiologico tra la PC e gli esiti psicologici e somatici: più i pensieri restano intrappolati in loop ripetitivi negativi, più il sistema nervoso autonomo perde flessibilità, predisponendo in tal modo l’individuo a disturbi emotivi e a problematiche di salute a lungo termine.
Cosa può essere di aiuto per correggere la tendenza a ruminare e preoccuparsi?
1) Mindfulness: protocolli MBSR e MBCT
I protocolli di mindfulness (MBSR/MBCT) sono molto utili poiché addestrano l’attenzione e la consapevolezza non giudicante: in tal modo aumentano la metacognizione (la capacità di essere consapevoli dei propri processi mentali), facilitano la disidentificazione dal contenuto mentale ruminativo (pensieri come fenomeni mentali e non “fatti”) e interrompono indirettamente il ciclo di mantenimento cognitivo dello stress. In clinica questo si traduce in meno ruminazione/worry, in una riduzione dei sintomi e nella prevenzione delle ricadute depressive. L’evidenza indica inoltre che le pratiche di mindfulness possono aumentare la HRV vagale (vmHRV) in modo acuto (durante lo svolgimento delle pratiche) e, in parte, anche a lungo termine pur con risultati eterogenei a seconda degli studi.
2) ACT: dalla “fusione cognitiva” alla flessibilità psicologica
L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), con il suo impegno a sviluppare la flessibilità psicologica (Sè come contesto, valori, azione impegnata, defusione, accettazione e contatto col momento presente), riduce l’impatto della fusione cognitiva (la tendenza a prendere i pensieri alla lettera, come fatti reali) che alimenta la PC.
3) Self-Compassion.
Coltivare un atteggiamento di auto-compassione riduce l’autocritica e la ruminazione e, sul piano fisiologico, si associa a valori più elevati di vmHRV (indice di migliore regolazione vagale).
CONCLUSIONI
Quanto a lungo restiamo intrappolati nei pensieri sullo stress? E’ importante ricordare che il nostro atteggiamento mentale (in particolare la tendenza a coltivare costantemente pensieri di preoccupazione sul futuro e ruminazione del passato - PC) gioca un ruolo molto importante per nostro benessere, ed è in grado di influire sulla nostra fisiologia, mantenendo il ciclo auto-rinforzante di risposta di stress. Imparare a riconoscere e lasciar andare i loop mentali, ad essere presenti e gentili con noi stessi e ad allenare il nostro ‘freno vagale’ (respiro, consapevolezza, gentilezza verso sé), aiuta mente e corpo a tornare in sicurezza, con positive ripercussioni importanti sulla salute psicofisica.
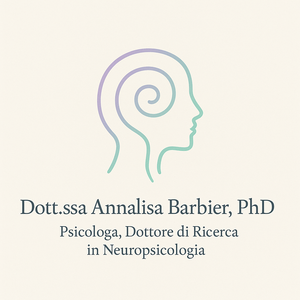



Scrivi commento