
Scritto da: Annalisa Barbier
Il filosofo contemporaneo Byung-Chul Han, nel suo saggio “La società senza dolore”, ci ricorda che viviamo in una cultura e in una società in cui l’esperienza del tocco che cura e che guarisce – il sentirsi toccati, accolti e interpellati dall’Altro – è diventata sempre più rara. Solitudine, narcisismo, competizione, autosfruttamento, espulsione della negatività e perdita di solidarietà creano dolorose fratture nel tessuto sociale e dunque nella trama di senso individuale, originando e amplificando un dolore che -privato del significato che lo narra come naturale risposta ad un contesto isolante e frammentato - e’ destinato a restare individuale, ad essere considerato sbagliato e inopportuno, sintomo insomma di disfunzionalita.
In questo scenario, i dolori cronici - soprattutto quelli dell’anima - non sono soltanto un fatto medico, ma soprattutto un sintomo socio-culturale: il corpo - e con esso l’anima - si fanno portavoce di quella richiesta di vicinanza, di amore e di attenzione che non trova spazio in una società guidata dalla sfiducia e dall’individualismo. Il filosofo Han sottolinea come nessun analgesico possa sostituirsi alla scena primordiale di guarigione: quel tocco dell’altro che è esperienza viscerale di accoglienza, cura e contenimento. È proprio quella mano- amorevole e guaritrice- il gesto relazionale e corporeo che restituisce al dolore una cornice di senso, rendendolo in qualche modo sopportabile.
Ed è proprio qui, in questa terra di mezzo, che si allunga un ponte e si apre il dialogo tra il dolore vissuto nella solitudine della negatività inaccolta, e il potere della compassione.
La self-compassion come “fai da te” del tocco lenitivo
La self-compassion rappresenta allora (nella sua versione divulgativa e semplificata) una sorta di “kit di emergenza” autosomministrato. I suoi insegnamenti e le sue pratiche permettono di offrire a se stessi quel tocco lenitivo che la società e le relazioni spesso negano, incapaci sempre più di legittimare una reale apertura verso l’Altro da sé (anche il dolore viene relegato ad esperienza di “altro-da-sé”). Non elimina il bisogno dell’altro, non sostituisce l’esperienza incarnata della cura relazionale, ma diventa:
- un ponte temporaneo, che ci permette di non soccombere al vuoto di senso di cui soffre il dolore nella nostra cultura, e alla disconnessione relazionale;
- una nuova memoria corporea, che rievoca dentro di noi, letteralmente “nel corpo” l’esperienza di essere accolti e contenuti;
- una cura verso di sé Auto-somministrata, che ci consente di accogliere e consolare il nostro dolore con quelle parole e quel tocco, gentili e accoglienti, che non riceviamo dall’altro;
- riporta a se stessi il ruolo della presenza dell’altro: l’altro diventiamo noi.
In altre parole, la self-compassion legittima il dolore, lo riconosce e lo rende abitabile, creando uno spazio di presenza proprio là dove la società tende invece a silenziarlo, esiliarlo nella disfunzionalità e medicalizzarlo.
Il paradosso dell’autoreferenzialità
Certo, la self-compassion porta con sé un limite intrinseco: è autoreferenziale. Nel toccarci - metaforicamente e fisicamente - siamo allo stesso tempo l’afflitto e il guaritore, chi soffre e chi consola. Potrebbe sembrare un surrogato fragile, incapace di sostituire davvero la mano dell’altro; eppure proprio in questa apparente limitazione risiede la sua forza:
- ci permette di mantenere vivo il gesto del “prendersi cura”, anche in assenza dell’altro;
- ci offre una base di sicurezza interiore - psicologica, neurovegetativa e somatica - che non cancella ma prepara il terreno per futuri incontri relazionali;
- trasforma il dolore in testimone della nostra vulnerabilità condivisa, ricordandoci del continuo dialogo esistente tra la dimensione individuale e quella universale.
La self-compassion è, dunque, insieme stimolo alla memoria e anticipazione: ricorda al corpo la scena primordiale della cura e, allo stesso tempo, lo prepara all’apertura all’altro, alla sua ricerca, alla sua accoglienza. Non vuole cancellare la ferita, ma sa lenirla e soffiare lieve su di essa, le dona una storia e con questa un senso. Non sostituisce l’altro, ma ne tiene vivo il ricordo e il desiderio. È un modo per non lasciare che il dolore resti un grido muto, ma possa farsi narrazione ricca di senso: un messaggio ascoltato e accolto, almeno da noi stessi.
In un mondo in cui il dolore, per dirla con Han, appare “svuotato di senso” e la buona vita è ridotta a “nuda sopravvivenza”, la Compassione (nei suoi tre flussi) si fa subito atteggiamento e gesto sovversivo: una delicata e potente forma di opposizione alla negazione del dolore, alla riduzione di senso e alla frammentazione sociale che ciò comporta.
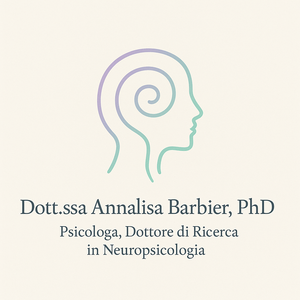



Scrivi commento